|
|
|
Questa visione pessimistica dell'uomo, debole, vizioso, umiliato
davanti a Dio, e' presente per tutta la durata del Medioevo, ma e'
piu' accentuata durante i secoli che vanno dal IV al X - e ancora
dall'XI al XII - mentre l'immagine ottimistica dell'uomo, riflesso
dell'immagine divina capace di continuare sulla terra la creazione e
di salvarsi, tende a prendere il sopravvento a partire dai secoli XII
Jacques Le Goff
Un candido manto di chiese copri' in quegli anni l'occidente
Radulphus Glaber, Chroniche
|
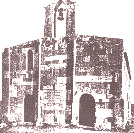
|
Poiche' la nostra lettura e' focalizzata sullo svolgersi del
rapporto tra recinto e percorso, e sulle sue implicazioni, e poiche'
il terzo modello e' una chiesa di epoca romanica con un impianto
strutturale singolare, una breve notazione deve essere fatta,
riprendendendo quanto detto circa la trasformazione che il luogo
sacro opera sulla struttura dello spazio e del tempo.
Lo spazio
sacro dell'antichita' classica, che diviene tempio una volta attuata
la cosmogonia, trasforma la realta' da caos a cosmo. Lo scorrere delle
stagioni, il quotidiano levarsi del sole, il succedersi dei raccolti
sono compresi ed interpretati alla luce di un modello eternamente
ritornante, fondato sulla ciclicita'.
La cristianita' introduce un
modello radicalmente nuovo di elaborazione cronologica, quello del
tempo lineare o temenico: il monaco attende la fine dei tempi per
vedere compiersi il disegno della creazione. Mundus senescit. Il
cristianesimo rappresenta quindi, almeno per l'occidente e sempre
nella visione di Mircea Eliade, la introduzione della
demitizzazione mediante l'elaborazione del concetto di sviluppo.
Noi abbiamo letto questo nuovo concetto di tempo, a buon diritto
rettilineo, univoco nel suo essere diretto ad un fine, come matrice
progettuale dei percorsi e degli spazi della chiesa romanica.
E' possibile identificare nel rapporto tra percorso portale/abside ed
in una serie riconoscibile di spazi/eventi successivi la logica
formale del romanico, con legami con la paleocristianita' e con il
modello
basilicale romano
ancora evidenti. La procedura struttura
due eventi necessari e una serie di possibili presenze che definiamo
accessorie, aree di transizione da un evento spaziale all'altro, ed
una serie di specificazioni logiche e formali via via piu'
articolate, in cui i criteri di stereometria, chiusura, matericita'
rispondono a richieste di formalizzazione successive ed inducono
ulteriori scarti di significato.
Questi eventi sono identificabili
tramite le loro interfacce: il portale di accesso, l'area dei
fedeli, l'abside. Ovvero la transizione dal caos al cosmo, dal
profano al sacro; la iniziazione del cammino, in cui si e' nel
cerchio magico ma non nel sancta; il luogo, l'annullamento dello
spazio e del tempo umani nella divinita'.
|
Modello tridimensionale dello spazio cristiano come individuato
nel paradigma indiziario. Sono evidenziati i diversi eventi
spaziali che procedono dall'esterno all'interno, dal profano al
sacro.
|
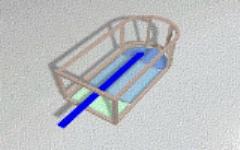
|
Una modifica sostanziale
arriva se leggiamo l'edificio come una precisa identificazione della
Chiesa con la immagine della Ierusalem Coelesti e con il corpo
crocifisso del Cristo. La chiesa e' il centro, e necessita di una
orientazione e di una quadripartizione che dia ordine al mondo. La
chiesa puo' divenire quindi croce, sviluppando l'incrocio tra navate
e transetto, innescando un processo di incremento della complessita'
del paradigma.
|
Incremento di complessita' del paradigma indiziario.
Assunzione di elementi eterogenei che inducono la formazione
della croce, prima orizzontale, poi pienamente sviluppata
nelle tre dimensioni dello spazio.
|
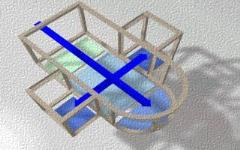
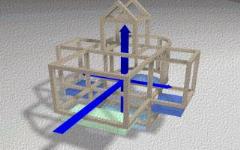
|
Il secondo momento adduce la verticalita': dalla
cripta alla risoluzione nel tiburio, la chiesa romanica struttura
ora su un ulteriore asse, axis mundi che lega la divinita' uranica
con la radice ctonia attraverso il mondo umano. Lo schema che ne
emerge e' qu ello di due croci ideali, aventi in comune l'asse del
transetto, poste ad angolo retto tra loro ed aventi la zona del
presbiterio come centro comune. Possedimento vittorino situato alla
periferia dell'abitato di Villaspeciosa a circa ventuno chilometri
da Cagliari lungo la strada statale 130, la chiesa di San Platano fa
parte del ristretto gruppo di chiese romaniche, esclusivamente
sarde, che presentano una struttura binavata. Eretta attorno al
Mille, la agiografia locale riporta la antica dedicatio
dell'edificio a due santi fratelli, Sant'Antioco e San Platano
appunto, come motivo della iconografia a due navate. La chiesa di
San Platano si presenta come una eccezione al nostro paradigma
indiziario.
La direzionalita' univoca dello spazio, per eventi
discreti sviluppati lungo l'assialita' della navata, che abbiamo
evidenziato quale schema di lettura del romanico, e' qui fortemente
caricato di ambiguita'. Le due navate gemelle, visivamente poco
distinguibili per dimensione, i due ingressi, le due absidi
centinate a filo: San Platano non e' una chiesa incompleta, e' un
deciso elemento di instabilita'. Questa particolare tipologia
bipartita non giunge alla negazione dell'asse primario tra il
profano e il sacro, che traversa la chiesa longitudinalmente come
sempre, non porta alla reinterpretazione di
modelli eterogenei
:
sdoppia solamente la chiesa. In questo modo, l'imbuto visivo verso
il portale maggiore del paradigma romanico maturo e' assente:
paradossalmente vi sono due vie per giungere a Dio. Questa bivalenza
implica un discorso circa la simmetria.
|
Modello tridimensionale della chiesa di san Platano.
E' evidente il processo di sdoppiamento lungo l'asse portale/
altare e la presenza di un duplice percorso che conduce dal
profano al sacro. Alterita'.
|
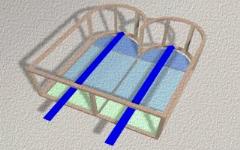
|
Il paradigma indiziario
iniziale non contemplava asimmetrie, elemento introdotto con le
letture di Stonehenge e del tholos di Atreo, e comunque non
assommabile:lo schema/sequenza cui fa riferimento San Platano non
ammette asimmetria delle parti, e l'immagine della chiesa sarda
risulta ambigua per questo: si tende ad osservarla come un edificio
a cui sia stata sottratta la navata maggiore centrale, come avesse
un asse di simmetria immaginario posto al centro della sequenza
arco/pilastro che divide internamente le due navate. Si fa fatica
ad orientarsi; e poi, quale sara' l'altare?
L'eccezione e'
sostanzialmente nella sua fondamentale inaderenza ad un modello
costantemente orientato alla disparita' e gerarchia dei percorsi:
una, tre navate, navata maggiore, stereometria. La chiesa di
Villaspeciosa, nella sua rispondenza tra le parti, recupera il tema
del doppio e lo rende di nuovo schema di lettura del cosmo,
dell'ordine simmetrico delle cose. Lo svolgersi ordinato delle
successive interfacce, portale/percorso/luogo, non viene minimamente
alterato, solo, e non e' poco, duplicato.
Modelli tridimensionali di chiese romaniche ed immagini
|


